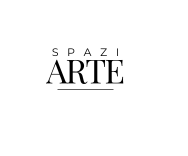La Galleria fu istituita nel 1784, quando il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo riorganizzò l’Accademia delle Arti del Disegno, fondata nel 1563 da Cosimo I de’Medici, nella moderna Accademia di Belle Arti. Il museo si arricchì con le soppressioni delle chiese e dei conventi ordinate da Pietro Leopoldo nel 1786 e da Napoleone Bonaparte nel 1810. L’evento decisivo per la storia del museo fu il trasferimento del David di Michelangelo da Piazza della Signoria nell’agosto 1873. La scultura più celebre del mondo attese nove anni, custodita in una cassa di legno, la conclusione della costruzione della Tribuna progettata dall’architetto Emilio De Fabris per accoglierla. L’odierna Galleria dell’Accademia fu istituita nel 1882.
La fama planetaria goduta dalla Galleria dell’Accademia e la costante affluenza di pubblico si devono all’impareggiabile nucleo di sculture michelangiolesche riunite qui in periodi diversi, per costituire una specie di mausoleo dedicato al mito eterno del grandissimo pittore, scultore e architetto.
La Galleria dei Prigioni ospita per l’appunto i quattro Prigioni concepiti per la tomba di Papa Giulio II.
L’altra scultura raffigurante l’evangelista Matteo pervenne alla Galleria dall’Opera del Duomo nel 1834 mentre la discussa Pietà da Palestrina conclude la serie di sculture: un percorso solenne che introduce alla vera e propria apoteosi della Tribuna, dominata dal David.
Ma la Galleria offre anche una delle più importanti raccolte al mondo di pittura italiana antica. I dipinti a fondo oro in particolare, dal Duecento al primo Quattrocento, illustrano la straordinaria fioritura dell’arte di questo periodo, con esemplari pittorici dei massimi artisti fiorentini del periodo quali: il Maestro della Maddalena, Grifo di Tancredi, Giotto, il Maestro della Santa Cecilia, Bernardo Daddi, Taddeo Gaddi, Andrea Orcagna, Nardo di Cione, Giovanni da Milano e Agnolo Gaddi.
Non meno ricco è il settore della pittura del Quattrocento, con opere, sul versante tardogotico, di Lorenzo Monaco e Gherardo Starnina; per il versante più rinascimentale sono presenti alcuni artisti di prima grandezza, quali Paolo Uccello, Alessio Baldovinetti, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio e Filippino Lippi.
La pittura del Cinquecento, esposta fra la Sala del Colosso, la Galleria dei Prigioni e la Tribuna, annovera capolavori dei maestri fiorentini operanti nei primi decenni del secolo per proseguire con opere degli artisti che aprono il dialogo della pittura con la scultura michelangiolesca contemporanea (da Fra Bartolomeo, a Andrea del Sarto a Pontormo), e da grandi pale d’altare che mostrano lo sviluppo della pittura fiorentina dell’epoca caratterizzata dalla forte influenza dei modelli michelangioleschi e ne documentano lo sviluppo che si indirizza verso la nuova spiritualità della Controriforma.
Domina la Sala del Colosso il modello del Ratto delle Sabine del Giambologna. Si tratta di uno dei rari modelli cinquecenteschi in terra cruda, realizzati in scala 1:1 per la versione marmorea scolpita nel 1582 e visibile sotto la Loggia dei Lanzi in Piazza della Signoria.
Altro nucleo collezionistico è rappresentato dalla Gipsoteca, che ospita le opere di Lorenzo Bartolini, uno dei più importanti scultori italiani a cavallo fra il Sette e l’Ottocento, acquisita dallo stato italiano dopo la morte dell’artista, insieme aigessi del suo allievo Luigi Pampaloni.
L’allestimento è completato con alcuni dipinti di maestri ottocenteschi che hanno studiato o insegnato all’Accademia.
Il Dipartimento degli Strumenti Musicali, infine, inaugurato nel 2001, ospita la Collezione del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze e vi si trovano esposti circa cinquanta strumenti musicali provenienti dalle collezioni private dei granduchi di Toscana, i Medici e i Lorena, raccolti tra la seconda metà del secolo XVII e la prima metà del XIX.
Spiccano tra di essi, la viola tenore e il violoncello di Antonio Stradivari, entrambi parte del quintetto realizzato nel 1690 per il Gran Principe Ferdinando de’ Medici, un violino Stradivari del 1716, un violoncello Niccolò Amati del 1650, una spinetta ovale e un clavicembalo in ebano, entrambi costruiti da Bartolomeo Cristofori.
Accanto ad essi si possono ammirare dipinti di autori come Anton Domenico Gabbiani e Bartolomeo Bimbi, che hanno rappresentato la vita musicale alla corte in quegli stessi anni.

Firenze
Titus Archibald